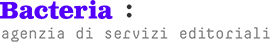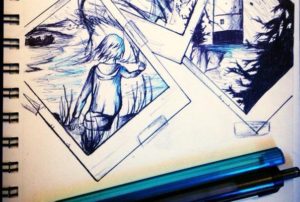Per scaricare il testo in PDF o epub, cliccare sui link:
C E N E R E
___________
Di Giulia Caminito
“È arrivato quello, il Giallo, sta fermo davanti alla stanza otto, te l’ho detto che venivano a prendere la Mano Mozza”.
Parlò così, e tirò su le gambe imbolsite, una e poi l’altra, le caricò, carne lessa, sulle lenzuola sporche di fuliggine, la sua pelle era cenere, lasciava tracce d’argento.
I Gialli erano sventura annunciata, sala operatoria.
La ragazza non rispose, gola cucita, ogni storia là dentro le faceva tremare la bocca.
“Adesso lo portano giù e sai gli strilli, Mano Mozza ha paura degli aghi”.
Era chiaro, d’acqua lucente, Mano Mozza gridò a Dio ogni sventura d’un esistere abietto, cavandosi gli urli dallo stomaco.
Stava lavorando al forno delle pizze, legna da ardere, gli era caduta una pala di ferro, l’aveva afferrata, era calda come il mezzodì del deserto.
La Vecchia conosceva tutti i dettagli, diceva: “Ogni racconto della gente di qui, ognuno di noi, ha portato alla palazzina C, piano dieci, l’Inferno di Dante. Noi siamo ignoranti, gente da bosco, uccelli da rovo, ma fidati, ragazza, abbiamo visto fiamme da santificare la peste”.
Come previsto dalla Vecchia, Mano Mozza iniziò a far voce da tromba, ché lui degli aghi non voleva saperne. Nel corridoio evocò tutti i santi e i loro sodali, perché marcissero sotto le pietre del pozzo più nero. “Non scendo, non scendo, cani, mastini, che non siete altro, bestie, coi vostri camici, portatori di sventura, cani, mastini, bestie, san Tommaso, santa Rita, santo accattone, santa assassina”.
Era mattina, la colazione già fredda, il pranzo al purè di patate, ciò che torna in eterno non fa più spavento, le medicazioni in attesa di giungere, la carne da strappare via.
Il cartello all’ingresso diceva: Reparto Ustioni.
*
La vetrata faceva scorrere sulle cose una luce d’alba tinta di sabbia, la manovella per la serranda era dura diamante, serviva un infermiere dal braccio fermo per far calare la notte nella stanza.
Sotto si contorceva un quartiere di Roma, architettura razionale, zone verdi a mucchi sparsi, case a tartaruga, villini, anatre spennate, lago d’improvviso balneabile. La distesa di ogni zona a sud dominata dalla torre impietosa di una sgangherata prigione. Ospedale Sant’Ambrogio.
Su una delle pareti: due armadietti. In uno, tre stampelle all’interno, una maglietta pulita, un maglione, la ragazza non s’era portata le mutande, le avevano parlato di day hospital, era finita tra i figli della misericordia, baciati dal fuoco, non c’era posto in altri reparti, non aveva neanche un libro, un giornalino da bar.
Al centro una sedia di legno, quelle solite dei banchi di scuola, a terra uno scatolone vuoto, sopra a questo un cuscino per far riposare le gambe alla Vecchia, piante dei piedi nere, cancrena sfiorata.
Se le massaggiava a ritmo regolare, tra un “che tribolazioni” e l’altro, le accarezzava come un bebè in fasce, mostrava le bende sulle cosce dicendo “queste sono speciali, si staccano da sole, sono tre settimane che stanno su, dall’intervento” e se le grattava tra un “son pene infernali” e l’altro.
Più avanti la porta del bagno, nessun lucchetto, puzza d’ammoniaca, pelle caduta, squame di coccodrillo, doccia di polvere, e un cencio spruzzato di disinfettante appoggiato al porta carta igienica, l’infermiera aveva detto “Lina”, che era la Vecchia, “dai una pulita quando t’appoggi, così la ragazza poi si può sedere”.
La giovane mai avrebbe fatto i bisogni seduta, l’aveva promesso sui Saggi di Montaigne, flebo alla mano, lacrime agli occhi, lo sguardo fisso su quel pezzo unto di garza, quello per “dare una pulita”, neanche per il Premio Nobel, piuttosto avrebbe subito i reumatismi di un equilibrista.
Una volta sola le era toccato, aggrappata alla divisa bianca di una dei Verdi, posare le natiche sul freddo della porcellana, pregando i numi sapienti di non venir contaminata da chissà quale disgrazia, perché non passavano i germi ma le malerie, le cose che facevano dolore.
Aveva ceduto, mugolando, quando sotto al sedere le avevano proposto la padella di cartone, dicendo “stai tranquilla non ti guarda nessuno”, e gli occhi della Vecchia, bende di sangue, le fissavano il bacino sollevato appena, “ma quanto è magra questa figliola”.
Allora proprio no, intontita dalla flebo, endovena sbagliato, due buchi sulla mano, di antibiotico e anestesia, aveva fatto segno di no con la testa, piuttosto che usare la padella sarebbe gattonata al gabinetto, portandosi dietro pure il letto d’ospedale.
Così era andata, la ragazza testarda aveva camminato malferma e si era infilata lì dentro, aggrappata a una delle Verdi, che le sbatteva in faccia due rotoli di divisa.
“Tranquilla puoi tenerti a me”. E si era aggrappata per non finire mento a terra, le sue ciabatte nere di plastica.
“Sangue chiama ferita, malattia chiama malore, colpa chiama pena” ripeteva la Vecchia da fuori.
Due letti vicini, potevano toccarsi le mani se le allungavano, i comodini ingombranti, i fili delle prese per ricaricare i cellulari troppo corti, il pettine zozzo di forfora, le bottigliette mai stappate di succo, le creme per la pelle secca, i fazzolettini umidi “non sai questi che sollievo”, forbicine per le unghie, “quasi non c’arrivo più, sono tutta di carta stagnola, faccio cric, faccio crac”.
Il pulsante per sollevarsi e mettersi sedute, di lentezza estrema, ronzio costante, il lenzuolo pulito tenuto male, che crolla giù, si infila sotto al sedere, la sciarpa posata sulle spalle, la cannuccia per bere l’acqua dal bicchiere di plastica.
A star sdraiate si vedevano i tubi sul soffitto annerito, veniva il mal di testa, era sempre meglio una mezza posizione, un respiro regolare, il tubicino trasparente che fa le bolle da sub, “morirò per un’embolia, assicurato, entro per due stupide tonsille e non esco più”.
Era il terrore comune: entrare, non uscire più.
Accanto al bagno la porta da cui sbirciare i movimenti fuori, gli andirivieni, i Verdi, i Gialli e i Professori.
Iniziava un mormorio, da bocca a bocca, “Sta arrivando il Professore, ora ti guarda lui”, in attesa del Vangelo, denti stretti, natiche asciutte, ginocchia gelatina, la benedizione, l’ostia, il vino, bevete il mio sangue e mangiate il mio corpo. Ad aspettare le dimissioni.
“Che dice, Professore, posso andare a casa?”, la nenia della Vecchia, un giorno sì e l’altro pure.
E lui no, scoteva il capo, capello brizzolato, “Ha tutta la schiena a carne viva, Lina, ma dove vuole andare? C’è un pericolo infezione che se la mangia, sabato forse, vediamo”.
“Che tribolazioni”, mani nei capelli, a piangersi addosso, occhi puntati sulla soglia, ché magari passava un altro P., un altro che la sapeva lunghissima, e la poteva salvare, un’anima pura, forse lui poteva farla uscire, acqua santa, rosario in pugno.
Ma i P. non la volevano liberare da quel tormento che Damocle s’era sognato, a ruzzolare giù per colline di spine, nelle notti dei fantasmi e dei bagliori.
La Vecchia sul suo letto fece incubi di crocifissione e svegliò la ragazza con quel “pomodori”, gridò “pomodori” gallina spennata, e dopo “i Mori, arrivano i Mori”. Poi si destò e fece alla giovinetta: “La nostra è una storia da condanna, colpa scellerata, colpa di fame e turbolenze, siamo stati puniti”. Alzandosi a stento per i bisogni della notte, aggiunse: “Noi sette siamo stati dannati”.
*
“Ce la fai a bere il succo di frutta?” le aveva chiesto una Verde il mattino dopo.
Aveva orecchini a forma di fragole.
No, non ce la faceva. Solo acqua. Senza tonsille le doleva tutto.
E intanto, era apparso il carrello della Lina. Le sue pinze, le sue forbici, le sue boccette, la sua garza imbevuta, le medicazioni, malumori per tutto il reparto.
La ragazza non sapeva se alzarsi e andare via, per non guardare e lasciar lavorare, ma a nessuno importava più di nascondersi, mettersi dietro i paraventi, non far spuntare la biancheria, gli odori molesti, la tosse col fazzoletto davanti, bisognava imparare a buttar via il pudore, sudore di troppo, ché tutti là dentro ti potevano spogliare, voltare a capo sotto, far camminare sulle spine, cinque pasticche, tre azzurre, due rosa, dritte in gola, ti faranno bene.
S’era fidata, era rimasta, mentre la Lina si denudava, seno di cuoio, ventre di grinze, zone rosa lisce e luminose, perlacee, aveva allargato le braccia: “Son pronta per questa tortura”.
Allora l’infermiera l’aveva scartata, caramella mou, strato dopo strato, sfogliata, ranuncolo, papavero, petali marci, scattivata al modo delle verdure che vanno raggiunte al cuore, doveva togliere le bende vecchie di tre giorni, e disinfettare, anestetizzare, passar la cura.
Ma le garze antiche erano diventate un tutt’uno con la pelle neonata, quella viva, che pulsava e tirava, bambola in ceramica, pronta a rompersi, l’avevano cinta, abbraccio d’amore, strette, modellate, sagomate sui bozzi e le rughe, i nei e le verruche, le croste secche; le bende le avevano unto e benedetto ogni ferita, erano una seconda epidermide, che segava alle giunture, gialla di umori, rossa di mercurocromo.
“Piano eh, piano”. La Lina aveva chiuso gli occhi, sputava aria fuori di bocca, una corsa trafelata, parto senza cesareo, guance rubizze, “piano eh, piano” pregava la Verde, di levarle con cautela, millimetri di gentilezza.
“Qui bisogna fare al modo dei cerotti, più si aspetta più fa male”, e via, aveva iniziato a tirare le bende senza troppi convenevoli, non stiamo a perdere tempo, ci sono altri mille pazienti in attesa, due letti, tre letti, quattro letti dove dovrebbero starcene due, dovrebbe starcene uno, anzi, quello è un sottoscala, lì sarebbe meglio non ci stesse proprio nessuno; e poi pronto soccorso intasato, gente che viene perché gli si è smagliata la gonna chiudendo il frigorifero e ora ha un dolorino, un dolorino sospetto all’orecchio sinistro, dottore è terribile, dottore, se entro non esco più, voglio star sulla soglia, datemi solo un’occhiatina.
Aveva tolto dal braccio, da sotto l’ascella, fino alla schiena, dove il fuoco s’era ingoiato quel che aveva potuto, spolpata.
La Vecchia urlò, scoiattolo scuoiato, cacciatore feroce, viscere sul pavimento, poi lo laveremo questo bel pellame, e lo stireremo, lo profumeremo, unguenti miracolosi, e lo appenderemo al muro, in sala da pranzo, dove più ci aggrada.
“Le madonne, neanche loro potrebbero salvarvi” gridava la Lina, ogni strappo una maledizione.
Strac, la sua pelle cadeva, le si toglieva di dosso.
Strac, non era più sua, copriva il pavimento.
La pelle l’abbandonava, come la notte dei pomodori, si disperdeva nelle mani degli altri, bruciata, arsa di solleone, il sole felino che vuol cuocerti i polmoni. Tutto le tornava in mente, alla Lina.
Togliamo le fotografie dalle pareti, stiamo lasciando questa casa inospitale, staccale, un colpo solo, sennò si rovinano, strac, lo scotch porta via pezzi di muro, strac, cade a terra quella foto del pentolone, sta sobbollendo, strac, tu lo assaggi, è sciocco, aggiungi il sale, chiama la Viola, dille di portare il sale, strac, granelli di vernice bianca, si sbriciolano, tirano via pezzi di te, strac, che cos’è questo rumore? Uno sparo nel bosco, strac, pomodori alle pareti, polpa e semi.
Arrivarono in due a tenerla ferma, questa Lina, che scalcia e fa la matta, come sono noiosi i vecchi, ma che dovranno fare mai con tutta questa pelle cadente e questi denti finti, le unghie ingiallite, i capelli sfilacciati senza colore, ancora due o tre anni e arrivederci, tante storie per niente.
Le avevano tolto ogni garza, lei respirava, mantice, occhi di fuori, il Professore aveva guardato, aveva detto purtroppo no, non è ancora guarita, altra flebo, endovena, garze nuove, e a letto.
L’infermiera aveva preso il disinfettante, il buon compagno dell’ustione, l’aveva versato dall’alto, scendeva, immergi le dita, bagna la fronte, segno della croce, detergeva la superficie, bruciore da manicomio, camicia di forza, bocca cucita a mano, spilli negli occhi.
Chiedi alla Viola di portare il sale, la salsa è sciocca.
“Che tribolazioni!” aveva ripetuto ancora la Vecchia, incredula, lacrime sotto cute, “queste non sono cose cristiane”.
Per far passare la retina e tenere su tutta quell’architettura di bende e fasce appena messe, le si era incastrato un braccio a mezz’aria e ora stava in tal maniera, dolorante, urlante, feroce, a dire che almeno qualcuno si degnasse di non trattarla come una triglia in mare aperto, provò a mordere una Verde.
Si videro tutti costretti a ricominciare da capo, via la retina che era stata messa storta, giù il braccio lungo il fianco, altri strilli, “mi toccate come fossi una pagnotta, sento tutto io, sento tutto, non sono fatta di mollica di pane”, tamponi sotto le ascelle perché così non sega, altro Verde più pacato e sorridente, quella quasi morsa se ne va sbuffando, per le due lire che le danno non vale la pena farsi prendere a schiaffoni, e alla fine le braccia della Lina erano passate. Era stata medicata tra gli altari e i confessionali, i bracieri, l’incenso e le vesti purpuree.
Così in cielo, così in terra.
Con occhi da licantropo guardò la ragazza, che a bocca spalancata aveva assistito alla svestizione carnale. Satanasso agghindato a festa aveva dato l’ostia in comunione.
“Novantanovepercento, mia sorella sta parcheggiata a Milano, reparto intensivo, ancora dorme, non trovano un donatore di pelle, è bruciata al novantanovepercento”.
“Lo vuoi il fegato per colazione?”. Rideva, amara di radicchio e disperazione.
*
Verso le undici arrivò la telefonata.
La Vecchia si mise a sedere, il cerchietto dentellato le aveva acconciato i capelli bisunti e resi lucidi dallo shampoo secco. Parlava in dialetto a un cellulare piccolo e nero.
Diceva alla figlia che stava bene, non c’era bisogno che venisse fin dalla campagna di Perugia a Roma, domandava del nipote, ci sono notizie da Milano?
Poi ripeteva che stava bene, forse l’avrebbero fatta uscire quel sabato, aspettavano la risposta di alcune analisi, sabato sicuro, se lo sentiva, mancavano pochi giorni e se ne sarebbe andata, anche se lì non stava male, non dovevano preoccuparsi per lei, c’erano o no notizie da Milano?
Alla fine dovevano averla fatta parlare con la nipote bambina, le si era rotta la voce, cristallo e vetri, la nonna sta bene, non darti pensiero, hai fatto i compiti? Mangi?
Io qui m’ingozzo come le regine, anzi come le anatre e i polli, ché le regine sono delle buone a nulla, arrosti e lasagne, vino rosso e confetti, dolci, ah quanti dolci, torte, bignè, la crostata di prugne, come la faccio io, anzi qua è meglio, non sai, la portano tre volte al giorno; s’incrina, si sta spezzando.
La vocetta della bambina usciva in pigolii, voleva rimettersi a giocare, tanto la nonna torna prestissimo, domani, anzi sabato, sabato hanno detto che posso uscire, mi metto con te a fare le polpette al sugo, sabato mi fai trovare la tavola apparecchiata.
La figlia doveva aver ripreso il telefono, le aveva raccontato qualcosa, la Vecchia s’era accigliata di nervi, gote strizzate.
Quel farabutto, quel mascalzone, passamelo! Non vuol parlare con me, eh? Ha il terrore che lo strigli, passamelo subito, aveva ruggito. Ma la Viola non glielo voleva passare. Aveva ripetuto, Viola passamelo, Viola passamelo. Senza risultato. T’ho detto che deve venire a parlare con me, ora, ché voi non siete buone a farlo andare diritto quello scellerato, è tutta colpa sua, queste tribolazioni, qui abbassò la voce, colpa sua e di questa sua mania, ancora c’ha le bende delle bruciature e già esce a fare la vergogna? Di’ ad Antonio di nascondergli… digli di metterlo via! Ci manca un’altra bravata, non gli è bastato? S’alzarono i toni, la Vecchia alla fine spinse il tasto rosso.
Guardò la ragazza, che fingeva di non ascoltare, occhi fissi sul televisore spento.
Non aveva neanche mezzo libro, senza copertina, senza metà delle pagine, per mostrarsi presa da altro. Un saggetto di cento righe, un pamphlet di cinquecento parole, sarebbe bastato un inserto culturale anche di tre settimane indietro, due mesi, del 1990, di prima che nascesse, anzi, sarebbe bastato Topolino, o i giornalini di Tex, piuttosto che stare a sentire la Vecchia.
Poi Lina s’alzo, cric e crac, chiuse la porta sul corridoio, restarono sole. Tutti fuori, i Verdi e i Gialli, i professori, i praticanti, i carrelli, i parenti in visita.
La giovane non poteva parlare, né lamentarsi, né saltar su e far baccano, se la trovò davanti.
“A te posso dirlo tanto sei muta, peggio d’una anguilla”, s’accostò felina, in gran segreto, movimenti lenti e denti gialli.
“Noi abbiamo una casa di campagna, come una volta, i capanni per gli attrezzi, le mucche, il pascolo, le messi, cani da caccia, ecco, soprattutto siamo gente da caccia, capisci che vuol dire? No, non lo capisci, voi mangiate tortini di melanzane grandi come gusci di noci. Be’ la nostra caccia funziona a suo modo, ha le sue regole, i suoi tempi, i suoi luoghi, quelli a cui è consentito sparare, le bestie a cui si può mirare, mi intendi? Sono cose santissime, le regole della caccia”.
La ragazza intendeva.
“Ma questo è l’inizio della storia, andiamo alla fine, è la fine che conta. La fine c’è stata quattro mesi fa, io, mia sorella, suo figlio, mio marito, suo marito, la fidanzata di suo figlio, il marito di mia figlia e mia figlia eravamo al capannone, dovevamo fare le conserve, ché io quelle messe nei barattoli dagli altri non le voglio, nossignore mangio quello che so da dove viene, lo devo vedere in faccia, persino i capretti, prima li guardo, poi li mangio.
Così le conserve e i sughi, la passata, ne facciamo tre o quattro pentoloni, coi nostri pomodori, non quelli di Gervaso che m’abita vicino, c’ha le piantarelle striminzite, le radici nere, la terra secca, noi usiamo solo i nostri pomodori.
E raccoglili, mettili in fila, lavali bene, sbollentali, pelali, è la festa della nostra domenica.
Chi prende le pentole, chi prepara i catini, chi versa l’olio, si fa un po’ di chiacchiera alla nostra maniera, chi urla di qua, chi prende in giro di là, siamo numerosi, te l’ho detto, siamo gente da bosco, amiamo le cose di terra.
Mio marito con mia sorella mettono a cuocere i pentoloni, io controllo, ché fan sempre guai, la bombola è accesa, il fuoco va. Due, tre ore, continua ad andare, noi lì intorno, i bambini giocano tra gli ulivi, mia sorella gira e gira.
Io assaggio, metto un dito dentro, bello pieno, porto alle labbra, faccio: è sciocca.
Allora mi viene un’illuminazione, mi volto, guardo la Viola, mia figlia, l’ho fatta io, l’ho spinta fuori tutta da me, niente medici, niente infermiere, a casa, tutta da me; me lo ricordo come se m’avesse messo Dio una mano in fronte, le dico: Viola prendi il sale in casa, ché qua è bello che finito.
Lei esce, gli altri restano dentro. Io resto dentro.
Faccio tre passi, non me li scordo più, i tre passi più lenti della mia vita: uno, due, tre.
Dico: Viola prendimi anche…
Lei non sente, non si ferma, la mano di Dio la spinge verso casa, come l’aveva fatta uscire da me, i suoi vagiti, la prende dalle spalle, la porta via, tiene i bambini nell’uliveto, la mano di Dio fa correre gli innocenti sulla collina, in alto, dove non vedono, la mano di Dio chiude i loro occhi, raccoglie con loro i sassi, li scaglia distanti…
Il capanno scoppia, al mio terzo passo, boom, la bombola non tiene più, pomodori dappertutto, io sento boom e mi butto a terra, sono sorda, sono cieca, boom, mi viene solo in mente che la Viola è andata a prendere il sale e poi nulla”.
*
La giovane aveva in gola la crosta del pane più scuro, quello di carbone. Non respirava di terrore.
“Devi imparare che non si rimane impuniti. Ah sì, uomini e cani, da loro si può fuggire, ma da Lui”, puntò il dito in alto, “da Lui no, neanche giù, in un fosso profondo”, puntò il dito in basso.
“Mio marito e mio cognato amano andare a caccia, ma son come tutti gli uomini, loro escono quando non è permesso, vanno a sparare quando non si dovrebbe, fanno inferocire i vicini, si aggirano tra le cascine, cercano i fagiani altrui, fanno razzia di galline, hanno la testa da bambolotti, sono due vecchi sregolati, contadini con la paglia in tasca.
Non serve chiedere perdono, ho tentato, mi sono inginocchiata, ho chiesto grazia, ho promesso che mai, mai più avremmo trasgredito, ho nascosto il fucile.
Tanto chi verrà a cercarci? Chi vorrà sapere?
Sono tutti poveretti che arrivano qui con i calzini bucati a far i lavoracci che noi del bosco schifiamo, chi vuoi che dalla città si prenda la briga? Avevamo pensato così, cara mia.
Nei nostri dintorni non ci sono solo gli animali, no, nelle terre a raccogliere sono arrivati questi Mori, questi ragazzotti che non dicono una parola e si prendono le paghe della fame, per il sole e le nuvole, per la pioggia e per la tempesta, non dicono A, lavorano e basta. Non si sa dove dormano, i Mori, ruderi abbandonati, casali senza tetto, roulotte ai bordi della strada, non si sa da dove vengano, a noi basta che raccolgano.
Io glielo avevo detto: non andare a caccia al tramonto, non si vede bene, sei mezzo cieco, sei vecchio, sei da camposanto. Ma mio marito era andato lo stesso, mia sorella gli aveva dato il fucile, e Lina quante storie che fai, per un paio di cinghiali, tutte queste moine.
Cosa faceva quel ragazzo lì, in mezzo alle fratte, per tutti i demoni e tutte le ossa sacre, cosa faceva, te lo sai? Chi mette a tavola l’agnello, chi lo mangia?
Mio marito l’ha creduto un orso, gli ha sparato.
Siamo andati in sette a vedere, la testa sfatta, aperta d’anguria, frattaglie al pomodoro.
Ci siamo detti, scava un fosso, a fondo, butta sotto, chi vuoi che lo sappia, chi li cerca questi, non hanno nome, non hanno famiglia, non hanno casa, sono arrivati dai porti, sono ricercati, fuorilegge, butta la terra, Antonio, la terra, pressala bene, pressala con le mani.
Mi sono inginocchiata, ho fatto un segno della croce, senza legno, senza chiodi, ho messo le mani nella buca, ho pregato.
Nessuno lo verrà a sapere, ha detto mia sorella, nessuno mai. Non serve che preghi, è una storia finita.
Fai come se avessi mangiato fegato a colazione, butta tutto giù, dimenticato.
Non ci si pensa, la prossima settimana vendiamo le passate, al casello ci saranno altri ragazzi come quello, sono tutti uguali, cosa importa? Ne prendiamo un altro, lo mandiamo da Gervaso, manco se ne accorge. Sottoterra si dimentica tutto.
Questa, ragazzina, è la storia per intero”.
La giovinetta aveva cacciato un basso fragore di inquietudine, e s’erano fissate, occhi a occhi, respiro da corsa giù per la collina, giù fino al fiume, per bere, riposare, prendere aria, dopo la confessione.
Prima che potesse volare un’altra parola, una delle Verdi spalancò la porta, le sgridò, c’era aria viziata lì dentro, fece entrare vento cittadino.
Poi disse alla ragazza che se l’antibiotico era finito, poteva rivestirsi, e andare via, erano venuti a prenderla, il dottore biondino s’era speso dicendo che era da mandare a casa.
“E io?”. La Lina aveva fatto uno scatto in avanti, come volesse inghiottire il vento. “Le mie analisi? Avete detto sabato, no? Oggi me lo fate sapere, vero? Devo andare da mia nipote e da mia figlia, mio marito, quello screanzato, non mi ascolta mai, devo andare nel bosco, sabato, me lo avete promesso”.
“Lina si sdrai, giù buona, non uscirà né oggi né sabato, ma chi le ha messo in testa questa novella?”.
La Vecchia era ferma, sasso lanciato, bende tirate, carne viva, mangiata, brasata, passata alla piastra, cotta a legna, fuoco alto, fiamma lenta.
La ragazza, per la prima volta felice di non poter parlare, aprì l’armadio, raccolse le sue poche cose, tolse tutto dal comodino, la Verde le sfilò, in un movimento solo, strac, l’ago cannula dalla mano, la pelle si distese, e la giovane levò la veste d’ospedale, toglierla era annuncio di guarigione.
Fece un gesto di gesso, sgretolato, alla Vecchia, spavento e aria da coniglio che vuole prendere a trottare verso un cespuglio, ficcarsi lì sotto, orecchie basse, e non sentire, non farsi contaminare dalle cose del bosco, uccellacci, lombrichi e lupi.
Uscì in pochi attimi dalla stanza, e la Lina restò sola.
“Ma sabato, ma sabato, voi lo avevate promesso” balbettò, denti costretti, a grumi e tocchi.
Passò poco tempo, un silenzio nero: uno, due, tre. Si voltò, tre passi.
Giunse un’altra ragazza, giovane, incanto d’estate, pelle di meringa, spina dorsale dritta, senza peso sulle spalle, altra operazione, altre tonsille, non poteva parlare, la misero al letto a fianco.
È arrivato quello, il Giallo, sta fermo davanti alla stanza otto, te l’ho detto che venivano a prendere la Mano Mozza, cani, mastini, bestie, santi, peccatori.
Lina, dai una pulita quando t’appoggi, così la ragazza poi si può sedere.
La padella di cartone che quella non vuole usare, quanta leggerezza, scapestrata, ma tu li conosci i mali della vita? Sangue chiama ferita, malattia chiama malore, colpa chiama pena.
Si affaccia il Professore, purtroppo no, ma forse sabato, chissà…
Entro e non esco più.
Noi sette siamo stati dannati.
Sono pronta per la tortura, il suo braccio fa la triglia nella rete.
Che tribolazioni, lo scalpo, lo strappo, lo scoiattolo.
Chiama la figlia, dice sto bene, non vi preoccupate, alla nipote, mangio dolci, mangio crostate alle prugne, ho la voce storta ma non sto per piangere.
Raccogli le more, le more nere, come quel ragazzo, nere come la sua fossa.
Hanno sparato nel bosco, uno senza nome. A chi vuoi che importi?
La salsa è sciocca, Viola vai a prendere il sale in casa. La mano di Dio, l’ha tenuta lontana.
Ciò che torna in eterno non fa più spavento.
Passò poco tempo, un silenzio nero: uno, due, tre. Si voltò, tre passi.
E poi ancora, nuova ragazza, nuova gola muta, nuovo giorno, nuova notte.
È arrivato quello, il Giallo, sta fermo davanti alla stanza otto, te l’ho detto che venivano a prendere la Mano Mozza, cani, mastini, bestie, santi, peccatori.
Lina, dai una pulita quando t’appoggi, così la ragazza poi si può sedere.
La padella di cartone che quella non vuole usare, quanta leggerezza, scapestrata, ma tu li conosci i mali della vita? Sangue chiama ferita, malattia chiama malore, colpa chiama pena.
Si affaccia il Professore, purtroppo no, ma forse sabato, chissà…
Ciò che torna in eterno non fa più spavento.
E poi ancora, nuova ragazza, nuova gola muta, nuovo giorno, nuova notte.
Ancora, ricomincia da capo, gioco dell’oca, riparti da zero.
Passò poco tempo, un silenzio nero: uno, due, tre. Si voltò, tre passi.
Ancora, ancora.
Ciò che torna in eterno non fa più spavento.
“Lo vuoi il fegato per colazione?”
Per una volta. Cento volte. Un milione di volte.
Noi sette siamo stati dannati, dal fuoco che lascia solo cenere.